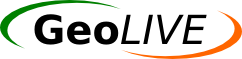Salve!
non ho potuto curiosare prima, perché dal convegno di Udine sono stato costretto ad una sosta ai box: pensavo di aver messo insieme un fisico da ragioniere, per esser finito in branda febbricitante senza motivo, ma ora che ho ricordato la domanda che ha avviato questo post mi consolo: forse lo shock mi ha prostrato e comincio solo ora a rimettermi in piedi :wink:
A parte gli scherzi, mi piace il buon proposito di Carlo di studiare in dettaglio la formazione dell'impianto.
E vorrei proporre qualche osservazione che mi sembra preliminare.
Diversi tipi di mappa Per le informazioni assunte fino ad oggi, si distinguono diversi metodi operativi: tavoletta pretoriana o celerimensura per il rilevamento; fogli non parametrati oppure parametrati per la restituzione.
Normalmente la parametratura è conseguente alla restituzione di un rilevamento celerimetrico, le cui poligonali sono state compensate per poi ubicare le stazioni tenendo conto della proiezione cartografica e della deformazione dei parametri.
In qualche caso, per diversi motivi che lo studio della storia potrà precisare, i fogli furono parametrati solo successivamente al disegno.
Per alcune zone, infine, risultano acquisite come "impianto" mappe preesistenti, che a volte sono state riprodotte variandone la scala, come ci è stato detto che sarebbe successo per alcuni comuni dell'Udinese.
Mi pare quindi che le informazioni sulle mappe delle varie aree potrebbero proficuamente essere raggruppate in una sezione di "testimonianze", auspicata già da Carlo, ed una casistica tematica per classificarne alcune caratteristiche chiave:
- celerimensura o tavoletta, preludono a differenti tolleranze e quindi a quelle che Carlo ha "battezzato"
tollerabilità - presenza di parametri all'origine, permette un efficace controllo sulle deformazioni intervenute sul supporto
- presenza di parametri posticci, dev'essere segnalata in quanto assolutamente ingannevole
- modalità di acquisizione aventi valenza giuridica, in quanto se i fogli hanno seguito le trafile previste per l'impianto, hanno la relativa valenza come documenti che riproducono la volontà allora espressa dalle Parti (almeno per le dividenti di possesso), mentre se riproducono documenti diversi, la loro efficacia sarà comunque a questi subordinata.
Rapporti con la ricerca di un confine Sulla falsariga ipotizzata, la ricerca delle informazioni utili ai fini della ricostruzione di un confine dovrebbe essere agevolata dalla classificazione descritta.
Rifacendomi alla specifica argomentazione richiesta da Geonik sulla parametratura dei fogli a stampa o con apposita dima, penso infatti che si possa sostenere che
non fa alcuna differenza per una riconfinazione, dal momento che entrambi i processi
precedono il disegno; e perciò questo ha tenuto conto dell'eventuale deformazione.
Altre notizie utili Possono incidere sull'approccio alle mappe disponibili, che non sono soltanto quelle relative all'impianto.
Poiché da più parti sento vagheggiare impieghi GIS tanto delle pericolosissime georeferenziazioni "ufficiali" dell'Impianto, quanto della mappa vigente, che ben sappiamo essere a gestione numerica, sorvolando sull'opportunità di sacrificare l'Impianto a questi fini, credo che sia invece ragionevole dedicarvi la vigente.
Perciò non sarebbe male censire anche i metodi usati, provincia per provincia, per costituire questa mappa. Per quanto ne so, in alcune province si è partiti dalle matrici Arcasol del Catasto Terreni, prive di aggiornamento, ma leggermente più accurate, mentre in altre province si è optato addirittura per il prodotto AGEA, puntando tutto sul massimo aggiornamento possibile, a scapito della qualità.
__________________
Mi sono dilungato forse eccessivamente, ma vorrei evitare il rischio che, per seguire l'affascinante materia storica, si perdesse di vista l'applicazione pratica, alimentando lo spettro di difficoltà dove non ce ne sono.
Leonardo