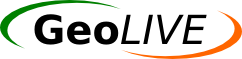|
News
07 Gennaio 2008 - rileggendo la storia del catasto.....facciamo discussione e considerazioni
tratto da Ing. Francesco Simonatti “Nel
cinquantenario della promulgazione della legge per la formazione del
Nuovo Catasto Italiano (1886-1936)
” Rivista del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali anno 1936, n. 6.
“... Dovunque esiste un catasto, ben fatto e ben conservato, con misure
e mappe figurate, anche se i suoi registri non facciano per se stessi
stato giuridico di proprietà o presunzione legale di essa; anche se il
catasto, da solo o in connessione con altri istituti, non abbia a tutto
rigore alcun carattere di probatorio, e non serva perciò ad accertare
se non uno stato puramente di fatto, il servizio civile che esso può
prestare è stato sempre e universalmente riconosciuto, e l’opera per
tale riguardo non ha patito eccezione.
Si potè esigere dal catasto (potè parere insufficiente talvolta) dalle
sue misure e dalle sue mappe o dalle sue intestazioni, alquanto di più;
ma in massima l’accoglienza è stata buona, e se ne apprezza il
vantaggio ogni giorno di più ...”.
“Angelo Messedaglia, Relazione parlamentare inerente alla L. 1° marzo 1886, n. 3682”
L’art. 1 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, ne definisce l’oggetto e lo scopo.
Sarà provveduto, a cura dello Stato, in tutto il Regno, alla
formazione di un catasto geometrico, particellare uniforme fondato,
sulla misura e sulla stima, allo scopo:
1) di accertare le proprietà immobili e tenerne in evidenza le mutazioni
2) di perequare l’imposta fondiaria.
Il nuovo catasto italiano era dunque:
- geometrico, ossia basato sul rilievo topografico;
- particellare, perché distingueva e rilevava i singoli appezzamenti di terreno
secondo il criterio del possesso, della qualità della coltura e del grado di produttività della medesima (classe);
uniforme, in quanto sostituiva tutti i catasti esistenti - che
erano in parte geometrici, in parte descrittivi, e comunque formati in
epoche diverse con metodi diversi - ed i criteri seguiti erano
applicati in tutto il territorio.
Il nuovo catasto era fondato anche sulla stima dei beni e non
sull’auto dichiarazione dei possessori come accadeva nel compartimento
ligure piemontese e nel meridione con le conseguenze che è facile
immaginare.
L’art. 2 precisa il concetto di misura introdotto dall’art. 1.
La misura avrà per oggetto di rilevare la figura e l’estensione
delle singole proprietà e delle diverse particelle catastali e di
rappresentarle con mappe planimetriche collegate a punti
trigonometrici.
Invece l’art. 9 riferisce che la stima dei terreni ha per oggetto
di stabilire la rendita imponibile, sulla quale è fatta la ripartizione
della imposta, mediante la formazione di tariffe di estimo, nelle quali
è determinata, comune per
comune, la rendita stessa per ogni qualità e classe.
Il reddito imponibile è quello medio ordinario (art. 11) ossia il
fondo deve essere considerato in condizioni di normale coltivazione da
presumere duraturo entro certi limiti di tempo; saranno escluse le
stagioni straordinariamente positive o negative, l’eccezionale o
pessima diligenza del proprietario.
Le operazioni che hanno portato alla formazione del catasto si distinguono in geometrico-topografiche e tecnico-conomiche.
Operazioni estimative:
qualificazione, classificazione,
3 - Caratteristiche del Nuovo Catasto
4 - La formazione del Catasto classamento, formazione delle tariffe.
Operazioni geometrico-particellari
triangolazione,poligonazione,
delimitazione e terminazione,
accertamento e intestazione dei possessori,
rilevamento particellare,
costruzione della mappa,
calcolo particellare.
Triangolazione e poligonazione:
Il territorio da rilevare è stato idealmente coperto da una serie di grandi triangoli collegati fra di loro.
La posizione dei vertici di detti triangoli è stata individuata con
coordinate, riferite ad un sistema di assi cartesiani, attraverso
l’impiego di opportune strumentazioni topografiche.
Tali vertici hanno costituito i capisaldi, o punti trigonometrici, del rilevamento.
Poiché i punti trigonometrici erano insufficienti allo scopo si sono
determinati altri punti mediante la poligonazione in modo che la
distanza tra i singoli capisaldi risultasse mediamente di circa 300
metri.
I punti calcolati con la poligonazione si chiamano punti poligonometrici.
Delimitazione e terminazione:
La delimitazione e la terminazione hanno preceduto il rilevamento particellare.
Con la delimitazione i periti catastali hanno eseguito la ricognizione
delle linee di confine dei singoli possessi provvedendo, a mente
dell’art. 68 del Regolamento 12 ottobre 1933, n. 1539, ad accertare il
nome del possessore nonché il modo o il titolo del possesso.
Il nominativo del possessore era acquisito in base al possesso di fatto
accertato anche con l’ausilio dell’assistenza fornita da una persona
esperta dei luoghi e scelta dalla Commissione censuaria comunale.
Nel caso di controversia sul nominativo dell’intestato il perito
del catasto procedeva all’intestazione del possessore di fatto
annotando anche il nome del contestatario.
Con la terminazione sono stati individuati, sul terreno, i punti più significativi delle linee di confine.
Intestazione dei beni:
Ai sensi degli artt. 7 del T.U. 8 ottobre 1931, n. 1572, e 54 del
Regolamento 12 ottobre 1933, n. 1539, i beni sono stati intestati ai
possessori risultati all’atto della delimitazione.
Rilevamento:
La delimitazione aveva circoscritto nell’ambito del territorio
comunale la cosiddetta particella di possesso ossia un fondo di
superficie continua appartenente al medesimo possessore.
Con il rilevamento la particella di possesso è stata frazionata in
altre particelle distinte per qualità di colture (seminativo,...
vigneto, ...), e per destinazione ( fabbricato, ...cortile,...).
Quando poi si procedette alla stima si suddivise la particella di
coltura per classe di produttività ( vigneto di I, vigneto di II,...).
Il rilevamento delle particelle e la rappresentazione in mappa sono stati così realizzati in tre diverse fasi:
1 - particella di possesso, in fase di delimitazione;
2 - particella di coltura/destinazione, in fase di rilevamento;
3 - particella di classe, in fase di stima.
Costruzione della mappa:
E’ consistita nel riportare, in determinata scala, il rilievo del
terreno in modo da ottenere una rappresentazione cartacea congrua con
quella del posto.
La scala adoperata ossia il rapporto tra la misura del disegno e
quella ricavata sul terreno, è stata principalmente 1 a 2000; sono
state adottate anche scale 1 a 1000 (zone molto frazionate) e 1 a 4000
(zone di campagna).
Si tenga presente che scala 1 a 2000 significa che 1mm (letto sulla carta) = 2000 mm (sul terreno) ossia 2 m; quindi 0,5 =
m 1 m ed ancora: 0,25 mm (letto sulla carta, cioè il segno della matita) = 0,5 m.
Non è dunque pretendibile, nelle comuni mappe catastali a scala 1 a
2000, riportare e leggere, con buona approssimazione, particolari
topografici inferiori a 0,5 m.
La superficie della mappa catastale è sempre inferiore a quella
del terreno perché il terreno vi è rappresentato proiettato
orizzontalmente e non esistono le quote.
Si dice che le mappe catastali sono mappe planimetriche ma vi sono
anche alcune zone del territorio le cui mappe mappe sono state
rappresentate in proiezione plano-altimetrica ossia mappe con riportate
le curve di livello.
Operazioni estimative
Le operazioni estimative hanno portato alla determinazione, per
ciascuna particella, delle tariffe di reddito dominicale e di reddito
agrario.
Il reddito dominicale è la parte dominicale del reddito annuo
medio ordinario per unità di superficie, al netto delle spese e perdite
eventuale.
Il reddito agrario la somma dell’interesse del capitale di esercizio e del compenso al lavoro direttivo.
A parere del Messedaglia il reddito dominicale, di natura
fondiaria, è il frutto della terra nel suo stato originario e quello
del capitale di miglioria stabilmente investito in esso quali le
piantagioni, i fabbricati rurali, le strade, i fossi,... mentre il
reddito agrario, di natura mobiliare, è il frutto del capitale di
esercizio investito nell’azienda e del lavoro.
Prodotto fondiario = terra + capitale + lavoro
terra = terra originaria + capitale di miglioria stabile
capitale = capitale di scorta viva e morta + capitale circolante
lavoro = manuale (contadino, ... impiegato,) + direttivo
Cooperano alla produzione:
per il fattore terra, il proprietario;
per il fattore capitale (+ lavoro direttivo), l’imprenditore agricolo o il coltivatore
o il proprietario se gestisce in proprio i fondi;
per il fattore lavoro, il contadino, il fattore, l’amministratore, l’impiegato.
Il reddito globale dell’azienda va ripartito in tre porzioni che rimunerano coloro che apportano i tre fattori:
il reddito dominicale rappresenta la parte del prodotto totale
spettante al proprietario quale apportatore del capitale fondiario;
il reddito agrario che va all’imprenditore agricolo o coltivatore;
il reddito di lavoro che, come salario o come stipendio, va
rispettivamente al lavoratore manuale ovvero a chi provveda
all’amministrazione e alla sorveglianza dell’azienda.
Qualificazione:
E’ consistita (art. 58 Regolamento 12/10/1933, n. 1539) nel
distinguere i terreni di ciascun Comune secondo le loro qualità di
coltura: seminativo, seminativo irriguo, seminativo arborato irriguo,
prato, prato irriguo, prato irruguo arborato, prato a marcita, risaia
stabile, pascolo, pascolo arborato, pascolo cespugliato, giardino,
orto, orto irriguo, agrumeto, frutteto, uliveto,
gelseto, colture speciali, castagneto da frutto, canneto, bosco di
alto fusto, bosco ceduo, bosco misto, incolto produttivo, incolto
sterile ed altre che si sono aggiunte quando se ne manifestava la
necessità.
Classificazione:
E’ (art. 60 Regolamento 12/10/1933, n. 1539) la suddivisione di
ogni qualità in tante classi quanti sono stati i diversi gradi di
produttività del terreno avuto riguardo alle condizioni fisiche ed
economiche influenti sulla relativa rendita netta. Per ciascuna qualità
e classe sono state individuate, in ogni Comune, le particelle-tipo
scelte a rappresentare il merito medio dei terreni da comprendere in
ciascuna classe.
Classamento:
Il classamento è stato effettuato al sopralluogo ed è consistito
(art. 75 Regolamento 12/10/1933, n. 1539) nel verificare la qualità
della singola particella catastale ed inserirla tra le classi stabilite
in fase di classificazione eseguito l’opportuno confronto con le
particelle-tipo.
Formazione delle tariffe:
Gli elementi presi a riferimento sono stati i prodotti, i prezzi, le spese e le eventuali deduzioni.
Le tariffe principali sono state ottenute elaborando prodotti,
prezzi e spese (di produzione, di manutenzione dei fondi, di
reintegrazione delle colture, di manutenzione dei fabbricati rurali, di
amministrazione) da considerare comuni a tutte le particelle di una
determinata classe; invece le tariffe derivate prendono in
considerazione soltanto una parte dei terreni di quella classe che sono
gravate da spese particolari (di irrigazione, di canoni d’acqua, di
fitto) e si ottengono apportando opportune deduzioni alle tariffe
principali.
La formazione del nuovo catasto dei terreni è stata molto lunga,
dal 1886 al 1956, e pertanto sono variati i periodi temporali di
riferimento in cui considerare gli elementi estimativi ma alla fine il
R.D. L. 4 aprile 1939, n. 589, ha precisato che i prezzi da applicare
ai prodotti ed ai mezzi di produzione dovevano essere riferiti al
triennio 1937-1939.
Riferimento all’azienda agraria:
Alla determinazione delle nuove tariffe si è giunti attraverso
l’analisi economica di aziende agrarie e la ripartizione dei redditi,
agrario e dominicale, tra le singole particelle costituenti l’azienda.
Inoltre i prodotti agricoli sono stati considerati nello stato di
trasformazione in cui vengono commerciati dall’azienda ossia il vino al
posto dell’uva, l’olio al posto delle olive ...
Bilancio aziendale:
Alla produzione lorda vendibile (p.l.v.) devono detrarsi:
• i costi delle materie prime occorrenti per la coltivazione quali sementi, concimi, mangimi, antiparassitari, ...
• somme erogate per noleggio di attrezzature e macchine, ...
• spese annue medie di manutenzione e di assicurazione e le quote di ammortamento del capitale di scorta,
• compenso per lavoro manuale,
• compenso per lavoro direttivo, di sorveglianza e di amministrazione,
• interesse del capitale di esercizio, fisso e circolante per ottenere il Reddito Dominicale (R.D.).
Il Reddito Agrario (R.A.) è uguale agli interessi del capitale di esercizio più il compenso per il lavoro direttivo.
Deduzioni fuori tariffa:
Le tariffe d’estimo si determinano al lordo delle spese per opere
permanenti di difesa, di bonifica e scolo, delle spese di irrigazione e
delle diminuzioni di reddito dovute a servitù militari.
Ripartizione del reddito fra le particelle dell’azienda:
Per le aziende composte di un’unica qualità e classe i redditi
unitari sono dati dal rapporto tra i redditi dell’azienda e la
superficie.
Il confronto tra i risultati ottenuti attraverso diverse aziende ha
permesso l’eliminazione di quelle che presentavano forti scarti.
Per le aziende composte da diverse classi o da diverse qualità il
procedimento è stato più complesso e si è basato sulla ripartizione per
successive approssimazioni.
5 - La pubblicazione del Catasto
I dati catastali scaturiti dai lavori di formazione, misura e
stima, sono stati pubblicati per dare la possibilità agli interessati
di proporre gli eventuali reclami interessanti sia la parte geometrica
che quella estimativa.
La pubblicazione avvenne in due fasi distinte: nella prima si
pubblicarono le tariffe d’estimo con i prospetti di qualificazione e
classificazione mentre, nella seconda, furono pubblicate i risultati
delle altre operazioni catastali; in
corrispondenza alle predette due fasi si distinguono due specie di reclami:
quelli generali, che riguardano le tariffe d’estimo, la
qualificazione e la classificazione, e sono riservate alla Commissioni
censuarie; i reclami particolari,che competono ai possessori e
riguardano il classamento, l’intestazione,
la delimitazione e la misura dei rispettivi fondi.
La pubblicazione riguardante i dati dei singoli possessori viene
eseguita con il deposito delle mappe e degli altri atti catastali nella
sede del Comune, sotto la sorveglianza dei periti catastali e della
Commissione censuaria comunale, e con l’assistenza del segretario della
medesima.
La Commissione pubblica un manifesto con cui viene notificato agli
interessati il luogo e le ore in cui le mappe e gli altri atti saranno
esposti per sessanta giorni, invita i possessori ad esaminarli ed a
presentare gli eventuali reclami nonché a denunciare tutte la
variazioni che nel frattempo fossero intervenute posteriormente alle
operazioni di classamento.
I reclami possono riguardare l’intestazione, ossia l’attribuzione
e appartenenza dei rispettivi beni, la delimitazione, figura ed
estensione, dei medesimi ed il classamento e le quote di ripartizione
dell’estimo fra i compossessori di una stessa particella.
Una volta che viene chiusa la fase di pubblicazione, l’Ufficio
tecnico del catasto esamina i reclami e le osservazioni, esegue le
verifiche sopralluogo ed eventualmente introduce, nelle mappe e negli
altri atti catastali, le variazioni
topografiche, le divisioni di proprietà e le rettifiche richieste.
Alle verifiche sopralluogo assiste un delegato della Commissione censuaria comunale.
Compiute le verifiche ed esaminati i reclami, il perito catastale
comunica gli atti alla Commissione censuaria comunale affinché, nel
termine perentorio di trenta giorni, decida in prima istanza e
trasmetta gli atti con le sue decisioni, all’Ufficio tecnico del
catasto.
Le decisioni della Commissione censuaria sono portate a conoscenza degli interessati, mediante deposito alla sede
del Comune.
Gli interessati, entro trenta giorni dall’avvenuto deposito, hanno
facoltà di ricorrere in appello alla Commissione censuaria provinciale
contro le decisioni della Commissione censuaria comunale.
La Commissione censuaria provinciale, entro trenta giorni
successivi a quello in cui le sono state consegnate gli atti deve
decidere in via definitiva sui reclami pervenutile, comunicare
all’Ufficio tecnico del catasto le decisioni prese e restituirgli gli
atti ricevuti.
Le decisioni prese in via definitiva dalla Commissione censuaria
provinciale sopra ciascun reclamo, vengono comunicate agli interessati
durante le operazioni di attivazione.
Chiusa la pubblicazione, l’Ufficio tecnico del catasto competente
per territorio, provvede all’allestimento degli atti necessari per
eseguire l’attivazione del catasto, e cioè:
a) la mappa particellare;
b) la tavola censuaria;
c) gli estratti partitari.
Con un manifesto da pubblicarsi in ciascun comune, i possessori sono invitati:
a domandare per iscritto la registrazione agli effetti del nuovo
catasto, delle variazioni avvenute dopo la pubblicazione dei dati
catastali, e di quelle che, avvenute anteriormente, non fossero state
denunciate agli Uffici di pubblicazione;
a chiedere la correzione degli errori materiali di fatto, e cioè
errori di conteggio, di scritturazione e simili, che si fossero
riscontrati negli atti;
a prendere cognizione del giudizio pronunciato sui loro reclami dalla Commissione censuaria provinciale.
6 - L’attivazione del Catasto
Come anticipato a proposito del Nuovo Catasto Terreni, nel 1864 si
era cercato di suddividere l’imposta fondiaria da esigere (lire 110
milioni) tra i nove compartimenti catastali e, all’interno di essi, tra
le province, i comuni ed i possessori (legge 15 luglio 1864, n. 1831 -
Conguaglio provvisorio dell’imposta fondiaria).
L'ordinamento dell'imposta sui terreni seguì gli avvenimenti già
descritti nella presentazione del Nuovo Catasto Terreni mentre
l'imposta sui fabbricati fu subito regolata dalla legge 26 gennaio
1865, n. 2136, denominata appunto legge per l'unificazione dell'imposta
sui fabbricati. Detta legge non poteva utilizzare il catasto fabbricati
perché tale catasto non esisteva né poteva prevedersi, a breve, di
affrontare l'onere per la sua formazione avendo il governo deciso di
privilegiare la formazione del catasto terreni la cui durata, come si è
visto, oltrepassò il ventennio.
La suddetta legge si basava sulla denuncia del possessore; la
denuncia era controllata dall'agente di finanza e da una commissione
comunale; nei casi di controversia interveniva una speciale Giunta
provinciale presieduta dal prefetto.
L'imposta era proporzionale al reddito netto con aliquota uniforme da determinarsi con un'altra apposita legge.
Il reddito netto era stabilito apportando una detrazione fissa al
reddito lordo; tale detrazione era di un terzo per gli opifici e di un
quarto per ogni altro fabbricato o costruzione, per tenere conto delle
spese di riparazione,
di mantenimento, di ogni altra perdita eventuale.
Il reddito lordo era costituito dal reddito effettivo risultante
dagli affitti in corso oppure dal reddito presunto corrispondente a
quello ricavabile in via
...........
La ricostruzione è stata difficile a causa dell'originale, molto....compromesso dai topi....
chi trova errori o inesattezze, me lo può comunicare anche con MP, grazie
Commenti:
|
 Ultime guide: Ultime guide:
 Ricerca moderatori per il forum: Ricerca moderatori per il forum:
Nell'ottica di migliorare la qualità dei post e ridurre i "flame", cerchiamo volontari per moderare uno o più forum di GeoLIVE, se siete interessati consultate direttamente il seguente post:
Grazie
 Convertitore da PDF a libretto DAT: Convertitore da PDF a libretto DAT:
Servizio gratuito che abbiamo realizzato per estrarre il libretto presente nel PDF rilasciato da SISTER e salvarlo come semplice file DAT da importare direttamente su PREGEO.
 SOLIDARIETA': SOLIDARIETA':
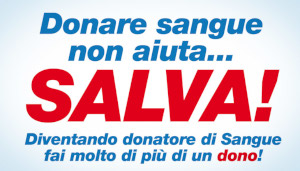
Visita il sito dell'AVIS (www.avis.it) per maggiori informazioni.
 Il nostro visualizzatore delle mappe catastali: Il nostro visualizzatore delle mappe catastali:
 Ultimi termini Ultimi termini
 Amici: Amici:
 Le nostre guide: Le nostre guide:
|
|